Di Fiat in Italia resta ben poco, Corriere del Ticino*. 22 giugno 2024
Che cosa resta in Italia della Fiat, che Mussolini aveva dichiarato con apposito decreto “azienda di particolare interesse nazionale”? Un primato che anche la Repubblica Italiana continuò di fatto a riconoscerle, tanto che i suoi nuovi modelli venivano presentati nel cortile del Quirinale, sede del presidente della Repubblica, e in sua presenza. Tutto sommato ben poco.
Fiat (originariamente: Fabbrica Italiana Automobili Torino) è soltanto uno degli attuali circa 15 marchi che contrassegnano auto prodotte dalla multinazionale Stellantis, società di diritto olandese con sede legale ad Amsterdam. Stellantis è una rara parola latina tratta dall’Eneide di Virgilio (aurea stellantis regia caeli, aurea reggia del cielo brillante di stelle) scelta nel 2020 dopo una laboriosa ricerca come nome di un complesso che comprende quelli che fino al 2019 erano i gruppi italo-americano Chiysler (in cui era già confluita la Fiat) e il gruppo francese PSA, i cui marchi principali erano Puegeot e Citröen.
È un complesso con la nascita del quale si compì l’operazione avviata nel 2004 dall’allora amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, e completata dopo la sua morte nel 2018 da chi gli è succeduto. Marchionne, italo-canadese e con una formazione marcatamente internazionale, si era reso conto che sul mercato dell’automobile, ormai divenuto planetario, non bastava più che i produttori fossero grandi aziende alla scala nazionale, e nemmeno alla scala continentale. Occorreva fossero gruppi di dimensioni intercontinentali.
Anche se il presidente di Stellantis è John Elkann, figlio di Margherita Agnelli e indicato come proprio successore da Gianni Agnelli (1921-2003), e la famiglia Agnelli è uno dei suoi principali azionisti, non si può dire che esista nel gruppo una particolare attenzione per l’Italia. I molti decenni di trattamento fiscale molto favorevole e di aiuti di Stato in cui largheggiarono sia il fascismo che poi l’Italia repubblicana non trattennero come abbiamo visto John Elkann dalla decisione di spostare la sede di Stellantis nei Paesi Bassi, e d’altra parte con la vendita nel 2016 del quotidiano di Torino La Stampa e insieme di quello di Genova Il Secolo XIX, al Gruppo Espresso di Carlo De Benedetti, Elkann ha lanciato un segnale chiarissimo tanto più se si considera che poi gli Agnelli sono divenuti azionisti di The Economist, il famoso settimanale inglese che fa opinione nell’ambiente dei manager delle multinazionali. In memoria della loro presenza nella vita cittadina gli Agnelli conservano a Torino soltanto la Juventus, che controllano dal 1923.
L’Italia non è altro che uno dei 29 Paesi del mondo in cui Stellantis ha degli impianti di produzione. I suoi stabilimenti italiani sono sei con circa 86 mila impiegati** complessivi. I tre maggiori sono quello storico di Torino Mirafiori, e quelli di Pomigliano D’Arco presso Napoli e rispettivamente di Melfi in Basilicata. Sono però semplicemente degli impianti di produzione riguardo ai quali ogni decisione viene presa ad Amsterdam. Dalle fabbriche italiane di Stellantis sono usciti l’anno scorso 752 mila veicoli, di cui circa 200 mila camioncini, una cifra molto lontana dal milione di unità che Carlos Tavares, l’attuale amministratore delegato di Stellantis, ha promesso di produrre in Italia entro il 2030. Se si considera che Stellantis ha attualmente circa 400 mila impiegati e produce complessivamente circa 8,7 milioni di veicoli all’anno, ci si fa un’idea di quale sia il peso dell’eredità della Fiat sull’insieme del Gruppo.
Nel 2021 Stellantis si posizionava al quinto posto tra i gruppi automobilistici mondiali dopo Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai-Kia; e prima di General Motors. La sua sede, come per altro anche quella di Renault-Nissan-Mitsubishi, è stata messa nei Paesi Bassi per motivi di convenienza fiscale, ma questo spostamento verso il Nord Europa finisce ovviamente per conseguenze anche reali sulla politica del Gruppo.
D’altro canto insieme a quello della Fiat hanno lasciato l’Italia anche i centri decisionali di molte altre grandi aziende manifatturiere tra cui la Pirelli e la maggior parte delle imprese che producono elettrodomestici. Diversa è invece la situazione nel settore delle banche e delle assicurazioni dove due grandi gruppi bancari, Intesa-SanPaolo e Unicredit, conservano il controllo del mercato nazionale e hanno anche una buona presenza all’estero, mentre Assicurazioni Generali è l’unica vera e propria multinazionale con sede in Italia.
*quotidiano della Svizzera Italiana
** nell’italiano della Svizzera impiegati significa dipendenti, siano essi impiegati o operai.


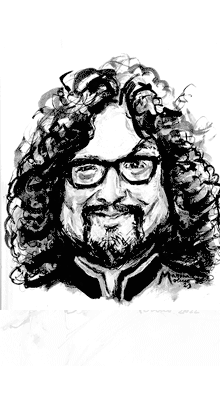






“La Fiat è sempre stata prontissima a privatizzare i profitti e a socializzare
le perdite”. Non ricordo a chi vada attribuita questa battuta, ma di sicuro non è lontana dalla verità storica.